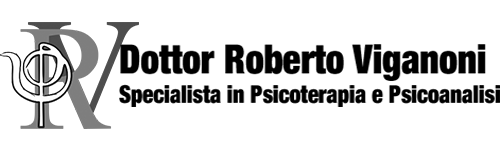“…un sano sviluppo mentale sembra dipendere dalle verità, come l’organismo vivente dipende dal cibo. Se la verità manca o è incompleta, la personalità si deteriora.”
- R. Bion
INTRODUZIONE
La comunicazione diagnostica nella pratica medica, ed in particolar modo nella pratica psichiatrica e psicologica è un aspetto centrale e da sempre combattuto e controverso sul versante etico-deontologico e clinico-concettuale (Paccaloni, 2006). Negli ultimi anni sono apparsi in letteratura alcuni lavori dai quali emerge l’importanza del coinvolgimento dei pazienti nel processo sia informativo che decisionale evidenziando il ruolo centrale di alcuni bisogni informativi da parte dei pazienti (Fenton, 2003; Macpherson et al., 2003). In particolar modo la relazione con il soggetto-paziente assume una funzione comunicativa centrale durante tutta la fase diagnostica e terapeutica. Tale relazione diventa fondamentale in particolar modo durante la fase di comunicazione diagnostica e dell’ eventuale indicazione terapeutica, sia di impronta psicologica che farmacologica. Non si può prescindere dal fatto che quando un medico, e forse, in particolar modo uno psichiatra, prescrive un farmaco egli somministri anche una quota di se stesso. Secondo Kendel (Kendel, 2005) la consapevolezza da parte del medico dei processi insiti in tale scambio comunicativo conferisce una valenza (psico)terapeutica al medico qualificando in tal modo il farmaco come “agente relazionale”.
Paccaloni e collaboratori (Paccaloni, 2004) hanno effettuato una revisione della letteratura scientifica sulle aspettative e sui vissuti dei pazienti psichiatrici verificando che il modello ad oggi più utilizzato nella pratica psichiatrica sia di tipo paternalistico; il quale può essere tradotto con la seguente formula: il medico sa e decide cosa è meglio per il paziente (Tarrier, Barrowclough, 2003). Su un piano ideale i medici considerano la condivisione diagnostica con il proprio paziente come un importante compito professionale, anche se ciò non sempre trova un riscontro empirico nella prassi clinico-terapeutica (Green, Gantt, 1987; Ono et al., 1999; Paccaloni et al., 2005; 2006). Varie sono le motivazioni addotte per una mancata o parziale comunicazione diagnostica. Fra le più comuni vi sono:
- La convinzione della mancanza delle abilità emotivo-cognitive dei pazienti necessarie per una comprensione puntuale della diagnosi;
- Il timore dello stigma sociale;
- Il vissuto negativo che potrebbe emergere dalla comunicazione;
- La tipologia di “diagnosi psichiatrica”;
- La sensazione che forse i pazienti in realtà non vogliano realmente sapere;
- Il timore che la notizia possa compromettere la relazione medico-paziente;
- L’assenza di tempo (adeguato) da riservare a tale processo;
(Clafferty et al., 2001; Schulze et al., 2003)
Paccaloni (Paccaloni, 2007) sostiene che nonostante le difficoltà ed i rischi legati alla comunicazione diagnostica sempre più i medici psichiatri sostengono l’importanza e l’utilità del coinvolgimento dei pazienti nel processo terapeutico, in quanto esso influenzerebbe positivamente il successivo esito prognostico. I fenomeni trasferali legati all’alleanza terapeutica permettono una migliore adesione al trattamento, una maggiore soddisfazione dei pazienti ed una miglior compliance terapeutica che si traduce nell’assunzione di un ruolo attivo nella gestione del disagio e nella possibilità di accedere ad informazioni puntuali attraverso la formulazione di domande ad uno specialista in grado di accogliere le richieste di un paziente che nel tempo è divenuto un “esperto” del proprio dolore (Little, 2001; Mead et al., 2002).
Per tutte queste ragioni è divenuto fondamentale adottare nella pratica psichiatrica e psicologica un approccio centrato sul paziente. Tale approccio affonda le radici in una concezione biopsicosociale delle malattie che si traduce in un modello olistico nella cura della persona affetta da patologie psichiche. Un approccio centrato sul paziente permette di stabilire il “che cosa” e il “come” dire, chiedere o rispondere al paziente in ragione dei diversi obiettivi che un clinico si prefigge, ovvero, le tematiche, i contenuti e le competenze comunicative che possono essere agite con profitto durante un colloquio e una restituzione diagnostica. Quest’ultima risulta di fondamentale importanza in quanto sancisce uno spartiacque durante il processo di consultazione. Un soggetto, carico della sua sofferenza, si rivolge ad un clinico, uno specialista investito di una “supposizione di sapere” per dirla con Lacan, che dia innanzitutto un nome al suo disagio e che, infine, possa attenuarlo. Il clinico deve quindi accogliere tale domanda di conoscenza e di aiuto sapendo rispondere in maniera adeguata alle aspettative del soggetto attraverso uno scambio comunicativo che vede il paziente non più come contenitore da riempire in senso paternalistico attraverso un sapere che piove dall’alto, ma come un soggetto attivo, un agente relazionale complesso con cui interfacciarsi. Tutto questo si traduce in un approccio centrato sul paziente.
Il presente scritto verterà in particolar modo sulla comunicazione diagnostica dei pazienti affetti da patologia ansioso-depressiva e sul ruolo che viene giocato dai familiari degli stessi prestando attenzione agli aspetti fantasmatici e simbolico-relazionali che connotano la relazione fra paziente, medico e farmaco.
IL CONSENSO INFORMATO NELLA RELAZIONE TERAPEUTICA
L’importanza di informare il paziente circa gli obiettivi terapeutici e le procedure che verranno utilizzate nel corso del trattamento ha assunto centralità negli ultimi anni, permettendo di definire la relazione terapeutica fra medico e paziente.
Numerosi sono i fattori che hanno contribuito a portare a consapevolezza l’importanza del consenso informato, in primo luogo la consapevolezza di abusi e di casi controversi che si sono verificati nel tempo. Importante è stato anche il cambiamento di prospettiva di “filosofia della cura”, che ha visto il passaggio dal un modello medico di tipo paternalistico, ad un modello medico centrato sul paziente.
Tutto ciò si colloca all’interno di una concezione moderna della medicina. Dal modello paternalista in cui la libertà decisionale del malato era ridotta al minimo, e il medico era l’unico referente decisionale per orientare la scelta terapeutica, si è passati al modello contrattualista che assolutizza la volontà decisionale del paziente che prevale nei paesi anglosassoni. Secondo tale prospettiva il rapporto tra medico e paziente viene visto come un «contratto» di cui possiede tutte le caratteristiche.
Tra paternalismo e contrattualismo vi è però una terza via, quella della cosiddetta alleanza terapeutica. Essa costituisce un impegno tra due (o più) alleati in vista del raggiungimento di un fine comune. Il criterio di alleanza terapeutica, non assolutizza nessuna delle due volontà: né quella del medico (paternalismo) né quella del malato (contrattualismo), ponendosi piuttosto come obiettivo la realizzazione di un fine «comune» cioè il bene del malato che deve essere ricercato e definito all’interno del rapporto fra medico e paziente. (Leone, 2010).
Tale rapporto vede il contributo del medico per quanto concerne le sue abilità, conoscenze e competenze comunicative, mentre il paziente manifesterà i suoi dubbi, timori, desideri, convinzioni e i “livelli di salute che intende perseguire compatibilmente con la sua unica e irripetibile situazione esistenziale” (Leone, 2010).
Una recente ricerca del Forum per la Ricerca Biomedica (Censis, 2009), pone in evidenza questo bisogno dei pazienti. Da quanto emerso dalla ricerca, i pazienti aspirerebbero ad un modello più collaborativo con il proprio medico (56% degli intervistati), mentre il 34% preferirebbe mantenere un rapporto di tipo paternalistico.
Essenzialmente il consenso informato permette la salvaguardia dell’autonomia del paziente dove per autonomia si intende “la capacità di decisione e di azione indipendente” (Messer, 2003). Il cuore del consenso informato risiede quindi all’interno dei principi di moralità comune del mondo secolarizzato, dove la tematica della comunicazione ha assunto negli ultimi anni un’importanza cruciale in tutti i campi dell’agire umano assumendo contorni del tutto peculiari per quanto concerne l’attività sanitaria ed in particolare il rapporto tra medico e paziente.
Le riflessioni sul tema e le ricerche in ambito nazionale ed internazionale hanno posto sempre più in evidenza il ruolo, decisivo, del paziente e, per certi aspetti non secondari dei familiari dello stesso, nel progetto terapeutico all’interno del quale si inserisce l’alleanza terapeutica.
Il soggetto paziente è divenuto protagonista attivo insieme al medico, e agli altri operatori sanitari che costituiscono l’equipe terapeutica interdisciplinare, oramai prassi comune di ogni progetto terapeutico che si basa sulla medicina moderna.
Il paziente si trasforma quindi da agente passivo, organo da curare, ad agente attivo sia del progetto sia dell’equipe terapeutica unendo il suo personale contributo al bagaglio di conoscenze tecniche ed esperienziali degli operatori sanitari.
Il consenso informato è quindi divenuto elemento essenziale all’interno di ogni buona prassi terapeutica. Prima di addentrarsi ad analizzare le varie forme di consenso informato e le sue diverse declinazioni, è opportuno effettuare una breve introduzione circa gli aspetti medico-legali che ne fondano la struttura.
A livello internazionale occorre far riferimento ad una normativa di notevole importanza, la Convenzione di Oviedo, sottoscritta il 4 Aprile del 1997 dal Consiglio d’Europa, dalla Comunità Europea e da vari altri Stati.
Gli Stati firmatari, riaffermando la dignità e l’identità di tutti gli esseri umani e dei loro diritti di libertà e integrità (art. 1), sancirono nell’art.5 la regola generale del “consenso informato”, statuendo che:
“Qualsiasi intervento in campo sanitario non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato il proprio consenso libero ed informato. Questa persona riceve preventivamente un’informazione adeguata in merito allo scopo ed alla natura dell’intervento nonché alle sue conseguenze ed ai suoi rischi. La persona interessata può liberamente ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento.”
Naturalmente la Convenzione disciplina anche i casi di persone incapaci di dare il proprio libero consenso, ad esempio: i casi di persone affette da disturbi mentali gravi (art.7); le situazioni di urgenza (art. 8) etc.
Si tratta di una disciplina articolata e complessa, che si pone perfettamente in linea con le norme costituzionali italiane.
In particolar modo il riferimento è a due articoli della Costituzione Italiana: l’articolo 13 e l’articolo 32 (secondo comma).
L’articolo 13 garantisce l’inviolabilità della libertà personale anche con riferimento alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica.
L’articolo 32 (secondo comma) stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e che, comunque, non possono essere violati i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Pertanto, i trattamenti sanitari, a meno che non siano obbligatori per legge o non ricorrano gli estremi dello stato di necessità o, ancora, il paziente non possa per le sue condizioni prestare il proprio consenso, sono di norma volontari.
Da tutto ciò si può dedurre che:
- il paziente è titolare del diritto ad autodeterminarsi in ordine ai trattamenti sanitari e pertanto, ove sia capace di intendere e di volere, il suo consenso non può essere sostituito da quello dei familiari (escluso il caso del minore, in cui il consenso è prestato dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale).
- La prestazione del consenso e la validità dello stesso da parte del paziente, presuppone una specifica informazione, proveniente dal sanitario cui è richiesta la prestazione professionale.
- Il professionista ha il dovere di informare il paziente sulla natura dell’intervento terapeutico, sulla portata ed estensione dei suoi risultati, sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili, sulla scelta tra diverse modalità operative, sui rischi specifici prevedibili (anche ridotti).
Tra medico e paziente si instaura quindi un vero e proprio rapporto di natura giuridica, che trova fondamento nel contratto di prestazione d’opera, disciplinato dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile. Dall’omessa informazione deriva, pertanto, per il professionista una responsabilità che trae origine dal rapporto contrattuale che lo lega al paziente.
L’obbligo di informazione del medico attiene alla fase precedente la stipulazione del contratto e rientra nell’obbligo del comportamento secondo buona fede, imposto dall’articolo 1337 del codice civile alle parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.
L’informazione del consenso deve quindi essere:
- preventiva;
- adeguata;
- relativa a natura, scopo, conseguenze e rischi dell’intervento.
Da ciò si deduce che il consenso deve essere:
- a) libero;
- b) informato;
- c) revocabile in qualsiasi momento.
L’importanza di informare il paziente può essere riassunta nella seguente tabella:
(Messer, 2003)
Secondo Beauchamp e Childress (2001) esisterebbero varie forme di consenso informato:
- espresso;
- tacito;
- implicito;
- presunto;
Consenso espresso – riguarda il “consenso firmato” dal paziente che, secondo gli autori, si inserisce nel quadro più ampio di cure mediche e ricerca.
Consenso tacito – riguarda un difetto nella comunicazione fra clinico e paziente che presuppone un soggetto “supposto sapere”.
Consenso implicito – è inferito dal clinico come conseguenza dall’adesione del paziente al trattamento;
Consenso presunto – è la decisione che il clinico ipotizza che la persona avrebbe dato se fosse stata capace di fornire liberamente il consenso. Tale prospettiva si discosta nettamente dal paradigma di moralità sopra menzionato.
Gli autori forniscono inoltre una distinzione fra Consenso Generico e Consenso Specifico. Il primo indicherebbe un accorto rispetto a varie procedure differenti, mentre il secondo riguarderebbe il consenso individuale che il paziente fornisce circa le procedure terapeutiche oggetto della sua cura.
Le condizioni affinché il consenso informato risulti valido sono:
- competenza;
- adeguatezza;
- informazione;
- volontarietà;
Competenza
La “competenza” è contemporaneamente un problema medico e giuridico; ovvero da un lato la capacità del paziente di fornire il consenso e, quindi, la competenza giuridica che lo Stato conferisce allo stesso come unico soggetto che può decidere circa la sua salute. Esiste in letteratura un dibattito circa la possibilità di definire un paziente “competente”. Secondo Beauchamp e Childress (2001) sarebbe necessario affinché il paziente possa definirsi competente la capacità di comprendere le informazioni rilevanti per la decisione; di apprezzare l’importanza che la decisione può avere per la sua vita; di usare ragionevolmente le informazioni ottenute per effettuare una scelta.
Informazione
Affinché il paziente possa fornire un valido consenso alla terapia è necessario che possieda delle informazioni valide circa i trattamenti e le conseguenze che da essi possono derivare.
May (1983) sostiene che la comunicazione al paziente delle informazioni circa il suo stato di salute e le eventuali terapie a cui dovrà sottoporsi ottenga risultati migliori se inserita all’interno di un’alleanza terapeutica fra medico e paziente.
Quest’ultima attiene alla relazione che si instaura fra medico e paziente e riguarda, secondo l’autore, una
- “comprensione empatica”;
- una “relazione consapevole”;
- un “accordo” che si crea fra due agenti relazionali attivi.
Volontarietà
Il concetto di adesione volontaria alla cura è sicuramente l’elemento di maggior complessità. All’interno di esso non convergono solamente le decisioni che riguardano soggetti in stato particolare, quali minori, gravi disturbi psichici o condizioni in cui i soggetti si trovano impossibilitati a fornire una autonoma adesione, ma riguardano anche elementi impliciti, come ad esempio quelli che si agitano nel substrato familiare del paziente. Ad esempio i membri della famiglia possono esercitare alcune pressioni sul paziente affinché egli aderisca ad alcune terapie. Inoltre il paziente può trovarsi in una condizione di dipendenza dal clinico. Si evidenzia qui l’importanza etica che riveste la relazione terapeutica in riferimento ad una alleanza che deve essere connotata dall’autenticità e dal rispetto dei principi deontologici che riguardano la pratica medica.
Quanto sopra espresso pone in evidenza una tematica cruciale: cosa fare quando un paziente non ha la competenze oppure rifiuta il consenso al trattamento.
Tale complessa questione potrebbe essere definita dalle seguenti tre domande: chi deve decidere? Rispetto a quali criteri? Quali sono i limiti?
La tabella seguente cerca di dare una risposta a tali interrogativi.
(Messer, 2003)
LA COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI AL PAZIENTE
L’atteggiamento del medico per favorire la comunicazione del paziente
Il dovere deontologico della rivelazione diagnostica spetta al clinico. Non di rado, soprattutto nei paesi latini, i familiari vengono coinvolti in prima persona. Per fare ciò il medico ha a disposizione un solo strumento: il colloquio. Il fine del colloquio è quello di fornire una informazione accurata e comprensibile al paziente e al contempo fargli percepire che fra lui e il curante esiste una relazione calda, empatica, una comprensione emotiva.
Nel momento in cui viene fornito al paziente uno spazio di ascolto emergono tutti i vissuti d’angoscia a cui il medico è tenuto a dare un contenimento.
Il rapporto medico-paziente si presenta potentemente all’interno di un rapporto oltre che tecnico, prettamente relazionale, psicologico, centrato sulla persona. La problematica della rivelazione diagnostica può essere risolto solamente attraverso un atteggiamento di ascolto empatico da parte del medico.
I problemi risultano ancora più complessi in quanto nella relazione medico-paziente entrano in gioco anche i familiari che con le loro reazioni possono esercitare una notevole influenza sull’equilibrio psicologico del paziente.
Comunicare diagnosi è sicuramente un compito particolarmente complesso dal punto di vista emotivo.
Back (Back et al. 2005) ha tentato di studiare questo aspetto individuando alcuni errori comuni che ricorrono spesso nella comunicazione curante-paziente e che sono fonte di stress.
Secondo l’autore i comportamenti da evitare sarebbero:
- evitamento: esso interviene, difensivamente, nel momento in cui il paziente ricerca una relazione o alcune informazioni alle quali i curanti rispondono attraverso l’elusione, l’evitamento. Tale atteggiamento ingenera nel soggetto un sentimento di frustrazione e di fallimento empatico che accresce lo stress;
- fare la paternale: si ha nel momento in cui il curante elargisce un numero considerevole di informazioni non lasciando al paziente la chance di rispondere e di metabolizzare le notizie. Tutto ciò ingenera nel paziente un sentimento di stordimento e confusione;
- collusione: interviene nel momento in cui il paziente esita nel richiamare l’attenzione su argomenti difficili e i curanti non forniscono loro delle risposte specifiche, limitandosi a informazioni elusive. Tale situazione potrebbe essere sintetizzata nella formula “non chiedere; non dire”.
- rassicurazioni premature: tali rassicurazioni si hanno quando un curante risponde al paziente attraverso rassicurazioni che vengono percepite dal soggetto come false, ambigue.
(Back et al. 2005)
Lo studio fornisce inoltre alcune indicazioni su ciò che bisognerebbe agire per promuovere una comunicazione che sia quanto più possibile corretta.
I comportamenti da incentivare sono:
- chiedere-dire-chiedere
questa idea si fonda sul presupposto che la conoscenza passa attraverso una co-costruzione. Come primo passo, secondo gli autori, bisognerebbe chiedere al paziente quali sono le sue conoscenze riguardo alla patologia. Questo permetterebbe al curante di formarsi un’idea sul livello di conoscenza del paziente, sul suo sistema di significati, sul suo stato emotivo e sul livello di istruzione.
Successivamente si dovrebbe dire al paziente, in un linguaggio che sia quanto più aderente al suo livello di conoscenza e di istruzione, cosa gli si vuole comunicare: una diagnosi nosografica, le opzioni di trattamento etc., così da permettergli di digerire le informazioni che successivamente gli verranno fornite. Durante la consultazione diagnostica infatti risulta fondamentale effettuare, da parte del medico, un intervento dal sapore psicoeducativo, spiegando al paziente quello che la scienza sa sulla sua malattia. Questo permetterebbe al paziente di non sentirsi isolato, ma agirebbe da rassicurazione, agendo sull’euristica di pensiero che “se si sa che cosa è, esiste anche una cura possibile”.
In ultima istanza si chiederà al paziente di fornire un riassunto di quanto detto, così da verificare l’effettiva comprensione delle informazioni che sono state fornite. A questo punto il curante può accorgersi che qualcosa è andato storto nel processo comunicativo. Per risolvere questa situazione, secondo gli autori, è fondamentale che il curante chieda al paziente di esporre cosa non ha compreso oppure quale aspetto della conversazione non gli è sembrata chiara. Questo permette al paziente di ottenere un riformulazione e lo mette nella condizione di sentirsi capito e supportato.
- “dimmi di più”
quando la conversazione con il paziente procede con lentezza, oppure si verificano dei blocchi e delle resistenze, gli autori suggeriscono di utilizzare tale strategia, che si articola su tre punti.
Come prima cosa occorre che l’operatore si ponga la seguente domanda: “che cosa sta succedendo in questo colloquio?”, questo permette di chiarire la modalità attraverso cui il paziente sta assorbendo le informazioni, osservando se non sia in atto qualche forma collusiva.
Il secondo passo riguarda direttamente la componente emotiva agita dal paziente nel momento del colloquio. Egli infatti si starà ponendo la seguente domanda: “cosa potrò fare adesso?” L’operatore dovrà, a questo livello, comunicare al paziente la sua vicinanza empatica, così da accogliere le istanze angosciose che vengono da quest’ultimo portate all’interno dello spazio comunicativo. Questo porta direttamente al terzo livello, in cui il clinico dovrebbe chiedersi “che cosa significa quanto detto per il paziente?”.
Gli autori suggeriscono inoltre alcune domande da porre al paziente per aiutarlo a esprimere meglio il suo vissuto. Ad esempio:
- “Potrebbe dirmi se desidera ricevere qualche informazione in più su quanto detto finora?”
- “Potrebbe dirmi come si sente emotivamente rispetto a quanto ci siamo detti?”
- “Mi potrebbe dire cosa questo significa per lei?”
(Back et al. 2005)
– sensibilità emotiva
la responsività emotiva del curante è fondamentale per il paziente, perché gli fornisce una cassa di risonanza a livello empatico. Questo fornisce al soggetto la sensazione di potersi fidare del curante, elemento basilare per la costruzione di una relazione terapeutica positiva che è considerato un elemento centrale anche a livello prognostico.
L’empatia, secondo gli autori, può essere ottenuta attraverso un approccio che viene dagli stessi sintetizzato nell’acronimo NURSE.
- N (naming) – dare un nome alle emozioni del paziente, restituendogli parte del suo vissuto;
- U (understanding) – comprendere i sentimenti del paziente;
- R (respecting) – riconoscere e rispettare le emozioni e il vissuto del paziente sia attraverso la comunicazione verbale sia non verbale;
- S (supporting) – supportare il paziente attraverso le fasi della malattia, ad esempio attraverso espressioni come “Sarò con lei durante questa malattia, per qualunque cosa potrà contare su di me” (Beck et al., 2005).
- E (exploring) – domandare al paziente di approfondire quello che ha appena detto, soprattutto a livello emotivo, permette al clinico di ottenere informazioni utili, e al paziente di sentirsi ascoltato e accolto.
Tab. 5.
| Stili di comunicazione efficace |
N = naming; U = understanding; R = respecting; S = supporting; E = exploring; |
(Back et al. 2005)
Una comunicazione attenta diminuisce l’ansia del paziente, rispetto a un disagio mentale che è ancora oggi ammantato da un’aura di mistero e timore. Tale informazione dovrebbe essere presentata in maniera chiara, restituendo al soggetto il suo vissuto emotivo e coinvolgendolo nelle scelte terapeutiche (Schofield et al, 2002).
Una procedura che aumenta la probabilità di fornire una informazione corretta e diminuisce i sentimenti negativi nei curanti, per quanto possibile, viene sintetizzata nella sigla SPIKES (Baile et al 2000; Back et al. 2005). Tale protocollo si articola in sei step con l’obiettivo di fornire una metodologia di comunicazione diagnostica. Utilizzando il protocollo SPIKES si raggiungono quattro obiettivi principali:
Tab. 6.
| Obiettivi del modello SPIKES |
|
(Baile, 2000)
I sei step del protocollo sono i seguenti:
- Setup
Si tratta di un momento preliminare in cui il medico si prende del tempo per verificare se possiede tutte le informazioni utili e per prendersi un momento di tranquillità, in cui prepararsi mentalmente un piano. Quando si troverà vicino, a contatto con la persona, il curante dovrebbe invitarlo ad accomodarsi in un setting che sia quanto meno asettico possibile, mantenendo un atteggiamento empatico attraverso il contatto visivo e un atteggiamento di apertura.
- Perception
Si tratta di comprendere qual è la percezione che il paziente ha della sua situazione di malattia. Per fare ciò potrebbe essere utile rispondere a domande come: “che cosa il paziente dice circa la sua malattia?” “che cosa si aspetta dal trattamento?” “quali sono i suoi obiettivi?” . Il curante in questa fase dovrebbe correggere tutti gli eventuali errori o false credenze del soggetto riguardo alla sua patologia.
- Invitation
In questa fase il curante dovrebbe comprendere quante informazioni il paziente desidera ricevere. La sensibilità del curante risulta fondamentale in questa fase.
- Knowledge
Secondo gli autori è importate che il curante si sintonizzi sul livello di istruzione del paziente adottando, quanto più possibile, il suo stile comunicativo. Questo permette al soggetto di comprendere le informazioni che gli vengono fornite. L’utilizzo di terminologie inappropriate per il livello di istruzione del paziente ingenera in esso dei sentimenti confusivi scarsamente produttivi.
- Empathize
Secondo gli autori è importante che il curante utilizzi la risonanza empatica per rispondere alle emozioni del paziente. Questo permette al soggetto di ottenere quel minimo di contenimento fondamentale in una situazione altamente stressante.
- Summarize and Strategize
Secondo gli autori risulta molto utile riassumere le informazioni e fornire un “piano d’azione”. Fare questo permettere al curante di verificare quanto il paziente è stato in grado di comprendere ed eventualmente correggere il tiro integrando le informazioni che eventualmente non sono risultate chiare al soggetto.
(Back et al. 2005)
| Comunicare la diagnosi attraverso il modello SPIKES |
| S (Setup) – iniziare preparando il contesto e disponendosi all’ascolto; |
| P (Perception) – valutare la percezione del paziente cercando di capire di cosa il soggetto è già a conoscenza e che idea si è fatto della sua malattia; |
| I (Invitation) – invitare il paziente a esprimere la propria volontà di essere informato o meno sulla diagnosi e prognosi della malattia; |
| K (Knowledge) – fornire al paziente informazioni utili per comprendere la situazione clinica; |
| E (Empathize) – aiutare il paziente ad esprimere la propria reazione emotiva cercando di rispondere ad essa in modo empatico; |
| S (Summarize and strategize) – discutere, programmare e concordare con il paziente una strategia che valuti la possibilità di intervento e i risultati attesi. Lasciare spazio ad eventuali domande. Rendersi conto di quanto il paziente ha capito e riassumere quanto detto. |
Tutto ciò si colloca all’interno dell’alleanza terapeutica ottenibile solamente attraverso un modello di cura centrato sul paziente (Miller et al, 2007).
In alcuni studi (Clafferty et al, 2001; Ucok et al, 2004) si evidenzia come a rendere difficoltosa la comunicazione diagnostica sia la tendenza del clinico ad attribuire al paziente reazioni emotive negative, che porterebbe il medico a temere di inficiare la relazione terapeutica. Secondo Paccaloni (Paccaloni et al, 2004) ciò porterebbe a sviluppare una sorte di profezia che si auto avvera secondo il detto che “se una situazione si percepisce come reale, sarà reale nella sue conseguenze”. Questo è dimostrato dal fatto che proprio l’assenza di comunicazione sarebbe alla base della perdita di fiducia dei pazienti nei confronti dei clinici.
Seale (Seale et al, 2005) riporta alcuni commenti fatti da medici psichiatri sulla modalità attraverso la quale avviare il processo comunicativo. Secondo l’autore si possono individuare tre elementi essenziali:
- La presenza di una solida relazione terapeutica; una sorta di base sicura;
- La trasparenza nella comunicazione;
- Il rispetto dei tempi del paziente;
Lo studio evidenzia come la modalità riferita con maggior frequenza per comunicare la diagnosi pare essere quella di partire dai sintomi riferiti dal paziente per inquadrali successivamente nel più ampio vissuto soggettivo così da giungere ad una comunicazione diagnostica.
Non si può non riferire inoltre che anche dal lato del medico psichiatra l’aver instaurato con i propri pazienti una collaborazione sulle decisioni terapeutiche presenta a livelli più elevati di soddisfazione personale(Hamann et al, 2006).
Da prendere in considerazione è anche la reazione del paziente di fronte alla presa di coscienza della sua malattia. Come per ogni altra patologia, anche la patologia psichica depressiva o ansiosa genera nel paziente intense emozioni quando viene inquadrata in una categoria nosografica.
Gli elementi che entrano in gioco in una comunicazione diagnostica sono molteplici. Vegni (Vegni, 2000) ne individua principalmente due: il contrasto cognitivo e l’agenda.
Il contrasto cognitivo riguarda due differenti registri comunicativi, il primo, del medico, organizzato secondo dati “oggettivi”, sintomi e categorie diagnostiche, il secondo, del paziente, organizzato per emozioni, problemi di vita etc. Se questi due differenti sistemi di riferimento non vengono tenuti in considerazione dal medico in fase di consultazione la comunicazione potrebbe divenire difficoltosa e inefficace.
Il secondo elemento che entra in gioco è l’agenda. Ogni paziente infatti tende a rispondere al proprio disagio utilizzando strumenti cognitivi, emotivi e relazionali propri, che differiscono per età, sesso, status sociale, cultura, aspettative etc. Tutti questi elementi, prendono il nome di agenda del paziente, e fanno riferimento agli elementi che ogni persona porta con se e con la sua malattia. Ad esempio:
- Teorie ingenue sui sintomi e sulla malattia;
- Aspettative;
- Emozioni;
Naturalmente così come esiste un’agenda per il paziente ne esiste specularmente una per il medico. Generalmente essa sarà costituita dal senso di responsabilità nei confronti di superiori, colleghi, familiari o istituzioni, da problematiche personali, da gratificazioni e soddisfazioni lavorative da benessere e qualità della vita etc.
Unendo le informazioni provenienti dalle due agende è possibile delineare gli elementi basilari di una comunicazione medico-paziente. Due sono gli scopi principali:
- Individuare e trattare la malattia;
- Comprendere l’agenda del paziente attraverso:
- La sollecitazione dell’espressione delle idee del malato verificando in tal modo il livello di conoscenza che quest’ultimo ha sulla malattia;
- Accertando le aspettative del paziente, effettuando un’analisi della domanda per scoprire le motivazioni profonde che hanno portato il paziente a rivolgersi al medico, proprio in quel momento (Carli, Paniccia, 2003);
- Riconoscendo i sentimenti del paziente e rispondendo ai suoi vissuti;
In tutto ciò grande importanza riveste il colloquio clinico. È infatti attraverso di esso che il medico entra in contatto con il vissuto del proprio paziente consentendogli di effettuare una diagnosi, stabilire una relazione e negoziare un trattamento. Putnam (Putnam, 1995) sostiene che un colloquio fra medico e paziente si caratterizzi per tre funzioni:
- Raccogliere dati;
- Creare una relazione terapeutica;
- Contrattare un trattamento;
Secondo l’autore durante il corso della consultazione il paziente non esprimerebbe direttamente i propri vissuti negativi, i propri timori, angosce, aspettative, ma lancerebbe al clinico una serie di indizi, i cues, e suggerimenti impliciti, i prompts, che, se colti prontamente, suggerirebbero la presenza dei contenuti specifici dell’agenda del paziente. In ciò consta una delle più importanti abilità del medico: saper raccogliere i segnali lanciati da chi si rivolge a lui, non solamente espliciti ma anche, e soprattutto, impliciti (in media un paziente riesce, nel corso di un colloquio ad esprimere meno del 25% delle sue preoccupazioni).
Le capacità comunicative che sono quindi richieste ad un medico si sviluppano su tre assi:
- Saper chiedere;
- Saper ascoltare;
- Saper restituire;
Saper chiedere riguarda la capacità del medico di porre le domande giuste nei tempi giusti. Cohen (Cohen, 1991) individua la strategia migliore, a suo giudizio, per raccogliere informazioni durante un colloquio clinico. L’autore evidenzia una strategia “a cono” che partirebbe da domande aperte per poi stringere con domande più specifiche nel corso della consultazione.
Saper ascoltare viene ben riassunto da Epstein (Epstein et al, 1993) con una metafora: “In qualità di medici abbiamo la necessità di ascoltare con entrambe le orecchie, cioè destinare simbolicamente un orecchio alla raccolta di informazioni biomediche, dedicando l’altro agli aspetti psico-sociali”.
Saper restituire riguarda la capacità del medico, una volta accolto ed elaborato le informazioni e i vissuti del paziente, di comunicare a quest’ultimo una diagnosi capace di dare un senso e un inquadramento al dolore che il paziente sta esprimendo.
L’atteggiamento del paziente di fronte alla diagnosi di depressione
La sintomatologia ansiosa e depressiva investe in maniera crescente la società industriale moderna creando disagi notevoli al singolo soggetto, al nucleo familiare e all’ambiente sociale di riferimento.
I medici di base sono le prime figure professionali a cui si rivolgono le persone che presentano un disagio legato all’ansia o alla depressione. L’Associazione per la Ricerca sulla Depressione ha effettuato un’indagine nel biennio 2006-2007 con l’obiettivo di individuare le opinioni più comuni e gli atteggiamenti dei pazienti nei confronti dei disturbi ansioso-depressivi e degli psicofarmaci.
Il questionario si costituiva di 20 item su scala Likert a 5 punti; per un totale di 532 medici intervistati che hanno fornito informazioni su circa 500.000 soggetti.
Per quanto concerne la qualità di informazioni che i pazienti possiedono, sia sul disturbo, sia sulle cause, sia sulle terapie, i risultati sono chiari. La maggioranza dei medici di base non ritiene adeguata l’informazione in possesso dei sui pazienti per quanto concerne la patologia ansioso-depressiva (65.6%).
(elaborazione nostra)
È interessante notare la differenza di quota di percentuale di farmaci ansiolitici o antidepressivi che vengono prescritti per la prima volta dai medici di base oppure dallo specialista psichiatra. Dalle maggior parte delle risposte si evince come la prescrizione sia primariamente effettuata dal medico di base (70% circa). Risulta quindi come sia estremamente frequente per il medico di base iniziare una terapia a base di psicofarmaci. La motivazione, secondo gli intervistati, sarebbe da ricercarsi nel timore che i pazienti manifestano per lo specialista psichiatra, che appare a tutt’oggi ammantato da un’aura di mistero e sospetto. Questi dati sono confermati anche da uno studio a livello internazionale (Liu, S.I. (et all), Non-psychiatric physicians’ knowledge, attidudes and behavior toward depression. J Formos Med Assoc, 2008; 107: 921:931). I risultati di tale studio sono riassunti nelle tabelle seguenti.
È inoltre interessante notare come esistano delle differenze nella credenza eziologica e sulla cura della depressione fra i medici generici e gli psichiatri.
È interessante osservare quali rassicurazioni il paziente richiede con maggior frequenza rispetto alla prescrizione di un farmaco ansiolitico o antidepressivo. Dai risultati dell’indagine dell’Associazione per la Ricerca sulla Depressione si evince come la preoccupazione maggiore che viene espressa dai pazienti riguarda l’eventuale dipendenza dal farmaco, 76,50%, il 13,34% richiede rassicurazioni circa l’efficacia terapeutica e il restante 10,15% si mostra preoccupato per un’eventuale alterazione dello stato di coscienza.
(elaborazione nostra)
E’ in questo preciso punto che si inserisce l’abilità comunicativa del medico che deve fornire rassicurazioni sull’efficacia e la sicurezza dei farmaci. La ricerca mostra inoltre come la maggior parte dei pazienti sia spaventata più dall’uso di antidepressivi (85.71%) che non dagli ansiolitici che, sembrerebbero essere diventati di uso comune nella popolazione.
Gli studi internazionali (Van Voorhees, 2005; Aikens, 2008) indagano le ragioni che spingono i pazienti a non accettare un trattamento farmacologico con antidepressivi.
Le tabelle seguenti ne analizzano alcune.
(Van Voorhees, B. et all. Beliefs and Attitudes Associated With the Intention to Not Accept the Diagnosis of depression Among Young Adults. Ann Fam Med 2005; 3: 38-45)
(Aikens, J.E. et all, Explaining Patients’ Beliefs About the Necessity and Harmfulness of Antidepressant. Ann Fam Med 2008:6: 23-29)
Bassa è invece la percentuale di pazienti che chiedono un antidepressivo in seguito al consiglio di amici o parenti (89%). Dai dati statistici nazionali si evidenza come su 6 milioni circa di persone che soffrono di depressione solamente il 25% arriva a consultazione da un medico di base o da uno specialista psichiatra. Il restante 75% resta nell’ombra; un dato che deve far riflettere.
Interessante è inoltre notare come non è detto che il paziente che riceve ed accetta la prescrizione di un farmaco antidepressivo segua poi le indicazioni terapeutiche. Molti pazienti infatti effettuano una modificazione autonoma della terapia, in genere in seguito al miglioramento sintomatico.
Dalla ricerca emerge come il 40% dei medici segnali che i propri pazienti abbiano effettuato un’autoriduzione della dose prescritta, il 36% abbia effettuato un’assunzione altalenate e il 24.06% abbia sospeso autonomamente l’assunzione del farmaco.
Il problema di fondo è quindi quello della compliance terapeutica, essenziale affinché il paziente assuma il farmaco correttamente e si abbia una remissione sintomatica completa e duratura. Da tenere in considerazione è anche la tendenza dei pazienti ad effettuare una sospensione improvvisa della terapia, con le conseguenze che da essa possono derivare.
L’alleanza terapeuta risulta essenziale affinché il paziente si attenga alle indicazioni fornite dal clinico.
(Peveler, R. (et all). Effect of antidepressant drug counseling and information leaflets on adherence to drug treatment in primary care: randomized controlled tral. BMJ, 199; 3-612-5)
(Rave, R.J. et all. Patients’ depression treatment preferences and initiation, adherence and outcome: a randomized primary care study. Psy Std, 2009, 60, 3)
(Mitchell, A. J., Thomas, S., Why don’t’t patients take their medicine? Reasons and solutions in psychiatry. Ad Psy treat, 2007, 336-346)
Altro aspetto importante da tenere in considerazione riguarda le aspettative che i pazienti nutrono per ciò che riguarda i farmaci ansiolitici e antidepressivi.
La ricerca effettuata dall’Associazione per la Ricerca sulla Depressione evidenzia come fra i pazienti dei medici di base intervistati il 38% abbia delle aspettative limitate alla riduzione sintomatologica, il 55% nutra delle aspettative miracolistiche di guarigione “magica”: “se assumo le compresse passa tutto!”, mentre il 7% non nutra aspettative né in senso positivo né in senso negativo.
Questo aspetto pone in evidenza il ruolo fondamentale dell’intervento psicologico nella cura di questo tipo di patologie per affrontare le cause profonde di un disagio sempre più presente all’interno della società moderna.
(elaborazione nostra)
Gli aspetti sopra esposti mettono in evidenza i vissuti e le credenze che i pazienti nutrono per gli psicofarmaci ed in particolar modo per i farmaci che agiscono nella patologia ansioso-depressiva.
Una interessante ricerca condotta da Aikens et all (Aikens, 2005) mostra le credenze che i pazienti nutrono rispetto agli antidepressivi attraverso il seguente schema:
(Aikens, pag 27)
(Aikens, pag 28)
Lo studio mostra come fra coloro che ritengono il farmaco non necessario, il 69% presenta un atteggiamento di scetticismo nei confronti dello stesso, mentre l’86% si mostra indifferente. Fra i pazienti che ritengono il farmaco necessario e utile il 95% presenta un atteggiamento ambivalente mentre il 97% lo accetta.
Questi dati si connettono con l’utilizzo che i pazienti fanno del farmaco. Precedentemente si sono riportati dati a dimostrazione del fatto che molti pazienti assumono incongruamente il farmaco, agendo una vera e propria auto-terapia, a volte inutile, a volte dannosa. Lo studio mostra come, a distanza di due settimane dalla prescrizione, il 21% dei pazienti inizino ad assumere il farmaco in maniera discontinua., mentre la metà del campione interrompe il trattamento a 4 mesi dall’inizio. Questo trova una spiegazione nell’azione degli SSRI che iniziano a far effetto circa dopo una quindicina di giorni. Nei casi di depressione lieve o di ansia è probabile che i pazienti non appena rilevino un miglioramento del loro stato di salute tendano a non ritenere più il farmaco necessario. Come già affermato è a questo punto che interviene prepotentemente l’alleanza terapeutica. È infatti probabile che se il clinico ha stabilito con il paziente un buon rapporto terapeutico, riuscirà a prevedere tale fenomeno nella maggior parte dei casi, o comunque a ridurne l’importanza.
Altro aspetto interessante è osservare come sono cambiate le rappresentazioni che i pazienti hanno rispetto alle cause della depressione.
Blumner e Marcus (Blumner & Marcus, 2009) evidenziano come nel decennio 1996-2006 le credenze dei pazienti rispetto all’eziologia della depressione si sia spostata notevolmente a vantaggio di credenze biologiste (77% nel 1996; 88% nel 2006). Questo porta i soggetti a preferire trattamenti farmacologici rispetto a trattamenti psicoterapeutici.
(Blumner & Marcus, 2009)
Il cambiamento di prospettiva veniva precedente rilevato anche dallo studio di Van Voorbes (Van Voorbes et all, 2005) mostrando come il 41% degli intervistati riteneva che la depressione fosse causata ha cambiamenti neurobiologici.
(Van Voorbes et all, 2005)
È interessante notare come esista una differenza etnica rispetto alla concezione dell’eziologia della patologia depressiva. È infatti evidente come all’interno della cultura anglofona sia maggiormente presenta la tendenza a considerare biologica la causa della depressione, mentre nei paesi europei tale tendenza è più mitigata a favore di altre spiegazioni. Ad esempio:
Nonostante lo studio dell’Associazione per la Ricerca sulla Depressione mostri come solamente il 14% dei pazienti accetti di rivolgersi ad uno psicoterapeuta per un problema di ansia o depressione la letteratura internazionale mostra come la maggior efficacia terapeutica si ottenga dall’uso combinato di farmaci specifici e specifiche tecniche psicoterapeutiche. Simon e Savarino (Simon&Savarino, 2007) mostrano come per la prevenzione del suicidio conseguente alla patologia depressiva i risultati migliori si ottengano nella combinazione di farmaco e psicoterapia. Dai risultati si evince come la presa in carico precoce del paziente depresso scongiuri la morte per suicidio.